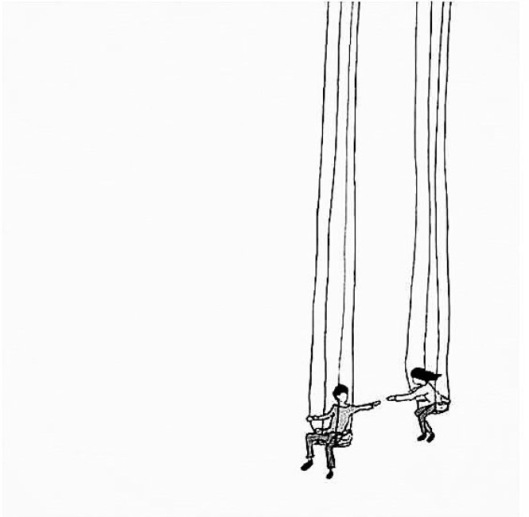 Oggi vorrei avere trent’anni.
Oggi vorrei avere trent’anni.
Non me la bevo la storia melensa su quanto sia bello godersi la strada, e che il senso della vita lo cogli mentre la scali la montagna, e non all’arrivo.
Io, oggi, voglio essere già in cima. E se la cima è più bassa di me quando avevo quattro anni, almeno lo so e la facciamo finita.
Via il dente, via il dolore.
Quantomeno non ci sarà più questa eterna incertezza che mi vede vestita di tanti ruoli diversi, senza realmente sapere se porterò almeno le scarpe.
Se non posso avere trent’anni strizzando gli occhi un altro po’, allora voglio averne venticinque e due mesi.
A novembre dell’anno scorso, iniziavo il mio praticantato. Allora le cose erano meno chiare di adesso, e c’era lo stesso entusiasmo di oggi. Mancava però la paura di non farcela, quella sensazione viscida e morbosa che conduce dritti dritti alla fatidica domanda: “e se invece non ci riuscissi?”.
Non c’era, un anno fa; ero troppo concentrata a capire dove fosse la linea di inizio per preoccuparmi di arrivare o meno alla fine. Ed era bello, era meraviglioso.
Malgrado tutto questo, è giusto che io sia qui.
È importante che io sia qui, a corsa già iniziata, col fiatone, i capelli rattrappiti sulla testa, le gambe indolenzite. È qui che si conduce la battaglia, in questo tratto di strada. Qui deciderò se mollare o proseguire. Perciò, anche se è il momento più duro, devo restare, devo danzare.
Mi è arrivato forte e chiaro questo concetto: è lungo circa cinquecento pagine, ed è tutto scritto nel libro Dance dance dance, di Murakami Haruki.
Il protagonista è un uomo che ho odiato fino a pagina trecento. Di lavoro “spalava la neve”, ossia scriveva articoletti frivoli su un giornaletto di basso valore. «Qualcuno dovrà pur farlo. Qualcuno dovrà pur spalarla la neve» – diceva.
Tutto il libro vive il contrasto tra questa attività così ridicolmente triste e il pianto misterioso di una donna sconosciuta in un albergo visitato molti anni prima.
«C’è una donna nell’albergo del Delfino. Sta piangendo per me».
Questa frase ridonda di continuo. Così, l’uomo che spala la neve decide di mettersi sulle tracce di chi “piangeva per lui” e durante la lunga ricerca, si chiede il perché.
Alla fine lo capisce: «Piange per me. Piange per quello per cui io non posso piangere». In una sorta di deflagrazione, l’uomo capisce che il motivo del pianto sta in tutto quello a cui lui si è arreso. La donna piange perché lui si è arreso a “spalare la neve” invece di lottare.
La ragione per cui io sono qui e non ho già trent’anni, o ancora venticinque, è che per me posso ancora piangere io; posso ancora piangere e poi rimettermi a danzare.
Questa è forse l’unica cosa bella: che ancora tocca a me, piangere o danzare. E nessuno può rannicchiarsi in un albergo a farsi cercare.
